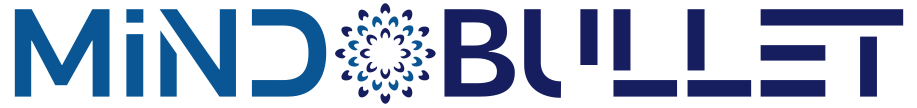E-Mail: [email protected]
- 6.400 militari in cura: triplicato rispetto al 2022.
- 21% dei nuovi pazienti con lesioni cerebrali o PTSD.
- Più di 64.000 soldati assistiti, 8.000 affetti da PTSD.
L’ombra del trauma: Israele di fronte a una crisi di salute mentale senza precedenti
L’intensificarsi del conflitto israelo-palestinese, iniziato il 7 ottobre 2023, ha innescato conseguenze disastrose tanto sul piano pratico quanto su quello emotivo per le persone coinvolte. Le cifre parlano chiaro: circa 6.400 militari hanno trovato accoglienza nel centro di recupero psichiatrico gestito dal Ministero della Difesa israeliano; questa entità segnala un aumento di tre volte rispetto al numero totale di veterani seguiti durante l’intero anno precedente, precisamente il 2022. Questa informazione allarmante evidenzia la serietà della crisi legata alla salute mentale che affligge il paese mediorientale: tra i nuovi pazienti, una percentuale del 21% presenta lesioni cerebrali o diagnosi attribuibili al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), assieme ad altre rilevanti affezioni psicologiche; inoltre, si prevede che altre migliaia di persone avranno bisogno di cure terapeutiche nei prossimi anni, in quanto la tensione causata dall’aumento delle operazioni in contesti urbani e dagli scontri ravvicinati continua a crescere senza sosta nelle trincee contemporanee del conflitto attuale. In questo frangente storico decisivo per Israele e la sua difesa nazionale, gli operatori sanitari assistono più di 64.000 soldati, dei quali circa 8.000 sono specificamente affetti dal PTSD.
L’impegno di Israele per la salute mentale: tra resilienza e nuove sfide
Nonostante la brutalità degli eventi, il popolo israeliano ha dimostrato una notevole resilienza. Tuttavia, la sfida principale rimane quella di fornire un adeguato supporto ambulatoriale ai pazienti affetti da PTSD, depressione e ansia. In risposta a questa crescente necessità, il sistema sanitario israeliano si è riorganizzato, aprendo nuovi ambulatori e reclutando medici specializzati. A seguito degli eventi del 7 ottobre, il territorio israeliano è stato suddiviso in dodici aree, con ogni struttura ospedaliera incaricata della cura di una specifica porzione territoriale. Questo schema di coordinamento ha reso possibile il trasferimento e l’assistenza celere di migliaia di persone. L’esercito israeliano ha inoltre implementato un sistema per la cura del PTSD nei soldati, mentre gli ostaggi ricevono supporto psicologico in ospedale. Il Professor Hilik Levkovitch, presidente e direttore del “Merhavim”, sottolinea l’importanza di investire nella salute mentale dei bambini, che rappresentano il futuro del Paese.

Le ferite invisibili: PTSD, traumi ereditati e la sofferenza degli operatori sanitari
Il conflitto bellico si svolge non soltanto sul campo armato ma anche nel regno psichico degli individui coinvolti. È allarmante constatare che il 30% dei militari feriti attualmente afflitti presenta lesioni di natura psicologica; tra questi, una percentuale pari al 60% sta affrontando l’incubo del PTSD. Tuttavia, è cruciale sottolineare come le conseguenze della guerra trascendano i confini dei soli combattenti: coloro che sono rimasti vivi dopo tali esperienze devastanti – siano essi operatori sanitari o educatori – subiscono anch’essi l’impatto drammatico della situazione attuale. In particolare, l’associazione ELI, dedita alla salvaguardia dell’infanzia in Israele, ha evidenziato un aumento nella richiesta di aiuto, correlata a dinamiche di maltrattamento, sia di tipo fisico che sessuale o emotivo. A ciò si aggiunge una difficoltà ulteriore derivante dall’eredità traumatica dell’Olocausto, il cui peso permane nella coscienza collettiva e viene trasmesso lungo le generazioni successive.
Strategie terapeutiche e prospettive future: un cammino verso la guarigione
Affrontare le problematiche mentali collegate a esperienze traumatiche implica l’impiego di un ampio ventaglio di metodologie terapeutiche; tra queste emergono la terapia dell’esposizione prolungata, oltre all’ EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Questo metodo è stato ideato negli anni ’80 dalla ricercatrice statunitense Francine Shapiro, e si avvale della stimolazione sensoriale tramite movimenti oculari accompagnati da input auditivi o tattili per facilitare una pronta alleviazione dei segni indicativi dello stress post-traumatico. Si attuano anche trattamenti psicoterapeutici tempestivi con la speranza d’ottenere rapidamente un’evoluzione favorevole nei pazienti coinvolti. Studi recenti eseguiti in Israele sul PTSD hanno dimostrato come tali disturbi possano perdurare persino per due decenni dopo gli eventi dolorosi. È pertanto essenziale offrire assistenza costante e specifica ai sopravvissuti all’incidente grave: ciò include frequentemente il coinvolgimento delle loro famiglie nel percorso verso il recupero completo. Come afferma il Professor Eyal Fruchter, è cruciale agevolare i reduci nell’esternazione delle proprie esperienze ed azioni quotidiane; questa modalità incoraggia attivamente regioni cerebrali associate alla conduzione delle attività mentre contribuisce alla diminuzione delle emozioni sfavorevoli.
Oltre la battaglia: la necessità di una tregua interiore
Nel quadro attuale caratterizzato da tensioni persistenti e cicatrici profonde all’interno della comunità israeliana, si rende cruciale l’atto di riconoscere ed affrontare le ferite invisibili. La sfida legata alla crisi della salute mentale si configura come estremamente articolata; essa necessita pertanto non solo di uno sforzo condiviso ma anche di un approccio diversificato coinvolgente molteplici discipline. È solo mediante una vera comprensione empatica ed assistenza reciproca che si potrà edificare un avvenire improntato alla resilienza ed al benessere collettivo.
Cari lettori, nell’attuale scenario globale così intricatamente collegato, diventa imprescindibile analizzare come esperienze traumatiche—specialmente quelle derivate da eventi bellici—possano esercitare effetti devastanti sulla nostra psiche. Alla luce dei principi fondamentali offerti dalla psicologia cognitiva appare evidente la connessione fra i nostri stati mentali: quando si verifica una situazione traumatica, scattano schemi disfunzionali nei nostri pensieri negativi capaci di alimentare timori ansiosi accompagnati da stati depressivi; questi possono sfociare nella tendenza ad isolarsi o ad evitare esperienze sociali.
Vi è inoltre una dimensione ulteriore: il fenomeno della neuroplasticità, che descrive l’adattabilità del cervello umano nel processo evolutivo delle sue funzioni anche successivamente ad eventi traumatici significativi. Ciò implica che grazie a un adeguato sostegno terapeutico accompagnato dall’impiego di strategie operative adatte, si ha la possibilità di ristrutturare eventi traumatici vissuti, alterando così i meccanismi del pensiero negativo e creando approcci alternativi per affrontare le sfide della vita.
Meditiamo insieme: quali strumenti siamo in grado di mobilitare per salvaguardare il nostro benessere psicologico ed aiutare coloro che ci gravitano attorno? In quale modo potremmo incentivare una cultura permeata da ascolto ed empatia capace d’accogliere e riconoscere esperienze altrui? Trovando risposta a questi interrogativi si potrà contribuire notevolmente alla creazione d’una società maggiormente resistente e consapevole.